Ed eccoci da 28 posti, chef Marco Ambrosino, procidano con una passione per il Mediterraneo, di cui valorizza la materia prima e le tradizioni. Marco Ambrosino gioca con gli ingredienti – ho sentito più volte, ieri, il termine “fermentato”, che in tutta la mia vita – e con le ricette dei popoli che si affacciano sul mare nostrum. Recupera tecniche e preparazioni, rendendole attuali, belle a vedersi e a gustarsi.
Arrivo alle 21:00, a Milano ancora non piove, ipotizzo una camminata fino al ristorante, ma i 4 chilometri di strada e i 6 gradi di temperatura mi fanno desistere in tempi record. 28 posti sono tre vetrine su una strada pedonale; l’ultima – o la prima – la cucina la condivide con la porta d’ingresso. Tanto legno, chiaro, luci soffuse, unico ambiente diviso in due da un mobile in cui pieni e vuoti si alternano, lasciando intravedere cosa c’è dall’altra parte, lasciando intravedere, finanche, la cucina, o immaginarla. La cucina non è a vista, si vede il pass e le mani che si muovono, generose e creative preparando meraviglie per i 28 ospiti o giù di lì. I tavoli sono vicini tra loro, questo – mi verrà raccontato poi – per favorire l’interazione, lo scambio tra commensali. Raggiungo il mio tavolo, alcune foto di rito, non tantissime, e mi accomodo.

Mi portano il menù che non guardo. Avevo già dato un occhio – più d’uno – al loro sito e avevo visto che i menù degustazione erano tutti e tre a mano libera, a sorpresa, cinque, otto o dieci portate, rispettivamente per 60, 80 e 90 euro. Opto per il primo: cinque portate con abbinamento di sei vini – bisogna sempre considerare entrée e cose, sia mai che una portata mi rimanga sguarnita di accompagnamento.
Allergie, intolleranze? Leggera intolleranza al lattosio, non mangio le melanzane e le cose che sanno troppo di mare. Per il lattosio, però ho il Lacdigest di cui faccio un uso smodato e inconsapevole. Quindi nessun problema.
Seduta da qualche minuto, arriva il benvenuto della cucina. Tre, serviti su tre piastrelle di ceramica. “La stella è uno gnocco fritto con crema di pomodoro secco. Poi, c’è una foglia di indivia, maionese al miso, cipolla rossa caramellata, germogli e polvere d’aceto e, per finire, un sasso con emulsione di erbe aromatiche e polvere di limone e un macaron al burro d’acciughe. Ah, il sasso non lo mangi. È un sasso vero. Lo lecchi e basta, prima di passare al macaron”.
Ah, lo lecco e basta. Ok.
Dopo qualche istante, arriva il vino, insieme con Alexia, o Alexia con il mio primo vino, dipende. Ecco, Alexia Poletti è uno dei motivi per cui tornerei da 28 posti stasera stessa. Di Torino, con origini thailandesi. Alexia ne sa una più del diavolo. Conosce vita, morte e miracoli di ogni vino presente in carta. Ha un fare ammaliante a metà tra lo snob, il fottesega, il formale, l’imperturbabile e il compagno di merende. Lei sa. E io mi sono lasciata condurre, per mano, per tutte le tre ore che sono stata seduta tra i 28 posti. Il primo vino è un vermentino di Gallura superiore, un Sarraiola del 2017 delle Cantine Raìca. Il produttore è un piemontese che ha deciso di comprare degli ettari di terreno in Sardegna. Il 10% delle uve viene da vendemmia tardiva, poi, una volta assemblate e passate in barrique, fanno un affinamento in bottiglia. La surmaturazione dell’uva andrà a compensare l’acidità dei piatti che mi aspettano: un altro benvenuto – una minestra di verdura e frutta su estratto di finocchio e olio al finocchietto – e il primo antipasto – un’insalata di rape e cavoli, tartufo nero, noce moscata e olio di argan.

Entrée

Sarraiola 2017 – Raica

Minestra di verdura e frutta su estratto di finocchio e olio al finocchietto

Insalata di rape e cavoli, tartufo nero, noce moscata e olio di argan
Tra le due portate, arriva anche una pagnottina di tumminia, grano antico d’origine siciliana, e il burro, che bellezza! Stavolta, il burro è affumicato e cosparso di polvere di cipolla bruciata, che faccio fatica a non pensarlo cacao. Forse il colore, forse il wine paring, forse l’amaro, non lo so. So solo che, a un certo punto, per farmi pane e burro in serenità, chiedo di rallentare il ritmo della degustazione.
Arriva il secondo antipasto e, con lui, il secondo vino. Picchi di entusiasmo quando riconosco nell’etichetta della bottiglia, la stessa che, appena una settimana fa, ho bevuto da Cordo, a Berlino. Alexia è incredula. Confrontiamo la bottiglia sul tavolo con quella ritratta in foto e no, a Berlino, della cantina Nestarec, Repubblica Ceca, ho bevuto I’m not e big wine, 100% Chardonnay, mentre qui parliamo di Love Me Hate Me del 2015, un Gewürztraminer in purezza, che fa un mese di macerazione sulle bucce, e altri 16, in botti di Slavonia.
[Tenetevele strette ste descrizione che, dal quarto vino in poi, ci godremo solo le foto delle bottiglie.]
Il vino, un orange wine, accompagna lo sgombro marinato con aspergillus luchensis, taramosalata, crescione, pomodorino e uva. Dove l’aspergillus luchensis è una spora con il sentore di mela renetta, mentre la taramosalata, una salsa a base di uova di pesce. L’acidità regna sovrana e il mio Love Me Hate Me, la stempera che è una meraviglia.

Pane di tumminia e burro affumicato con polvere di cipolla bruciata

Love Me Hate Me 2017 – Nestarec

Sgombro marinato con aspergillus luchensis, taramosalata, crescione, pomodorino e uva
Lasciatoci alle spalle lo sgombro, entriamo nel vivo della degustazione con uno dei, credo, piatti signature dello chef: lo spaghettino, acqua di pasta fermentata, miso di cicerchie e legumi. Mi piace tantissimo. Alexia ha accennato alla tecnica per ottenerlo. Una roba complicatissima che parla di muffe e spore. Però, poi, ha detto che era un segreto e che mi avrebbe dovuto uccidere se me lo avesse rivelato. Io volevo dirle che non sarebbe stato necessario e che la mia memoria fallace avrebbe provveduto, comunque, a cassare il tutto in pochi minuti. Fatto sta che gli unici appunti di senso compiuto parlano di spaghetti cotti per 7 minuti in acqua di pasta fermentata. FINE. Ma questo credo sia solo la punta dell’iceberg. Per chi volesse approfondire la questione, Vice gli ha dedicato un pezzo qui. Lo spaghettino lo abbiniamo con uno Stella Flora del 2014 di Maria Pia Castelli, un “bellissimo assemblaggio” di Pecorino, Trebbiano, Passerina e Malvasia che fa 15-20 giorni di macerazione sulle bucce e 18 mesi di affinamento in barrique. Decisamente il vino della serata.

Spaghettino, acqua di pasta fermentata, miso di cicerchie e legumi

Stella Flora 2014 – Maria Pia Castelli
Il piatto della serata, invece, è stato quello che mi sarebbe arrivato da lì a breve: Agnello in tre portate, dove la carne è servita in tre preparazioni diverse, tipiche di tre zone altrettanto differenti, che si mischiano e fondono, perché le tradizioni migrano e si contaminano e danno vita a qualcosa di nuovo, di cui l’origine, alla fine, chissenefrega, ciò che conta è che sia buono. E lo era. Terrina di agnello glassato con cavolo nero e salsa romesco, burek lievitato e zuppa forte di interiora, cevapcic, curry mediterraneo e cetrioli fermentati mi ha fatto letteralmente impazzire.
Da cosa inizio?
Alexia alza gli occhi al cielo: “Mangia tutto insieme e smetti di fare foto, scrivere, perdere tempo, altrimenti si raffredda tutto”, intanto mi porta due vini rossi, di cui allego foto. Mi avvicino i tre piatti. Per la terrina, uso la forchetta, la polpetta, il cevapcic, lavorata sulla costoletta dell’agnello, la mordo avidamente, la pitta la porto alla bocca con le mani. A giro. E intanto bevo. Una giostra bellissima, goduriosa e divertente.

Terrina di agnello glassato con cavolo nero e salsa romesco

Cevapcic, curry mediterraneo e cetrioli fermentati

Burek lievitato e zuppa forte di interiora

Casa e Chiesa 2017 – Tenuta Lenzini

Lorano 2014 – Maria Pia Castelli
Sono quasi allo stremo delle forze. Manca il dolce. Prima un sorbetto di shiso – basilico giapponese – sale e olio all’alloro e poi il mio dessert: Ricotta, cenere di agrumi, gelato al polline e bottarga di muggine. Allora, io sono per i dolci dolci e non amo la bottarga. Quindi il dolce non rientrerà tra i preferiti della storia, però ci ho bevuto su un vino epico. Cavolo avevo detto che il vino della serata era stato lo Stella Flora, ma l’Anforghettabol della Cantina San Biagio Vecchio è stato bellissimo. Uve botritizzate e un anno di macerazione sulle bucce in anfora georgiana, acciaio e affinamento in bottiglia per un paio d’anni. Da impazzire, la storia e lui, di cui, generosamente, ne ho bevuto due calici.

Ricotta, cenere di agrumi, gelato al polline e bottarga di muggine

Anforghettabol – Cantina San Biagio Vecchio
Chiudo con la piccola pasticceria – notevole il cioccolato bianco, rosmarino e gel al limone – e un tonico analcolico fatto con 15 erbe aromatiche e il saluto dello chef, cui faccio i miei complimenti. Che la cucina è un viaggio e stasera lo è stato per davvero. Una cucina senza confini, in cui ti sposti tra le diverse zone del Mediterraneo, in cui mangi con le mani, in cui lecchi i sassi, in cui strappi a morsi – anche un po’ meno – la carne dall’osso.
Una cucina bella e spericolata. In cui si osa e ci si diverte. Una sala giovane e sorridente. Armonia. Ogni cosa, da 28 Posti, ha un significato, ogni cosa, una storia da raccontare. L’ultimo ricordo è legato all’elemento su cui poggiavano i petit four, opera del designer Odo Fioravanti. Il Mago di Oz, un treppiedi, i cui piedi sono il ricordo, l’uno dello spaventapasseri, l’altro del leone fifone e l’ultimo dell’uomo di latta. Frutto di un progetto che lo chef e il designer hanno studiato insieme: No Place like Home. Figo. È ora di andare. Sono l’ultima a lasciare il locale, come al solito. Prendo il taxi e torno a casa. Due giorni di Milano stra. Ho mangiato da paura. Che Roma è fenomenale – campanilismo? – ma Milano stavolta mi ha davvero lasciato a bocca aperta.

Tutto è bene quel che finisce bene

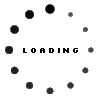
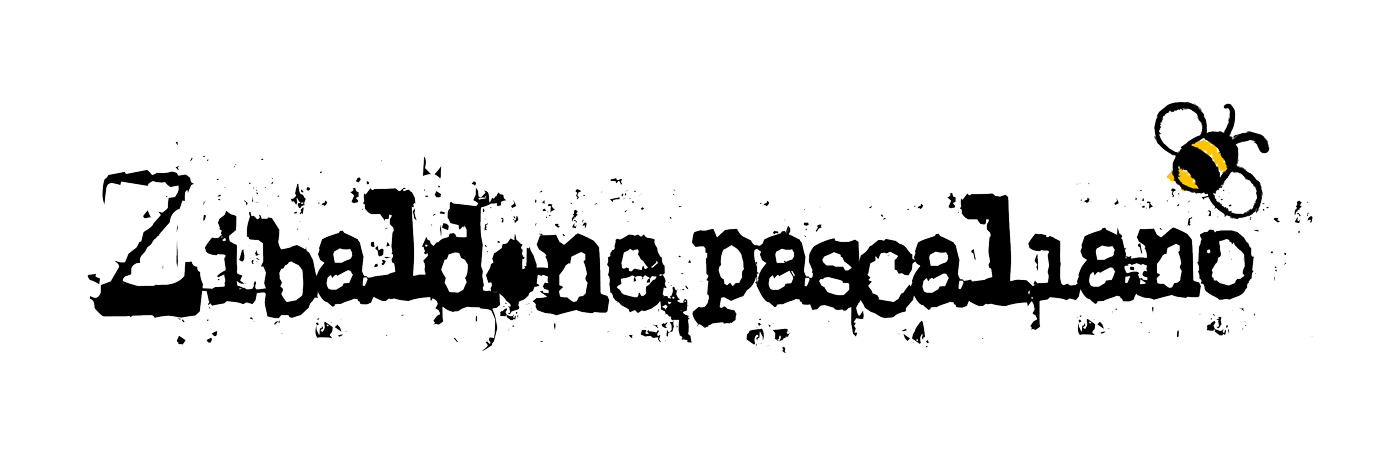




Leave A Reply